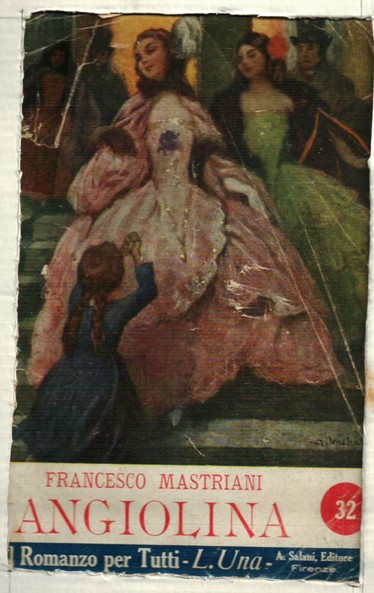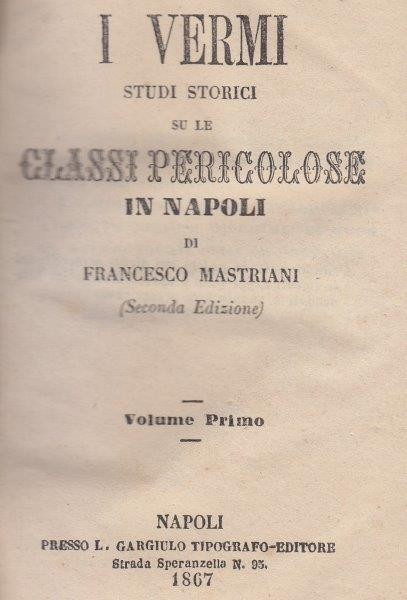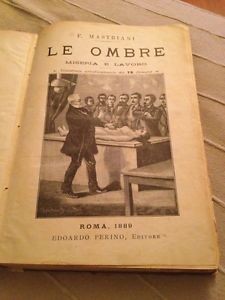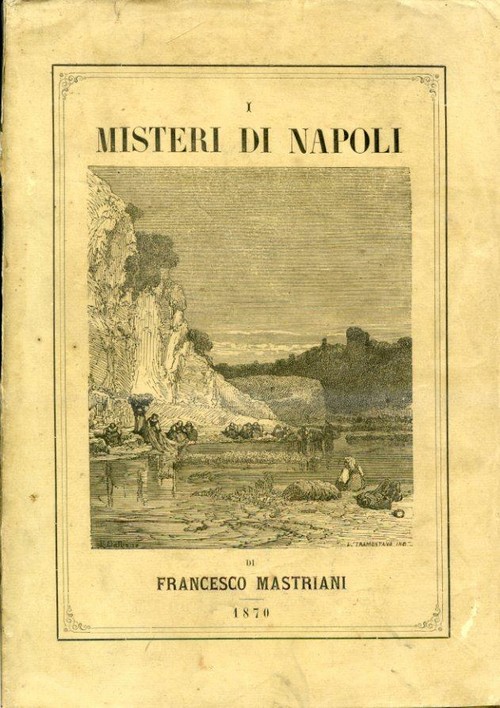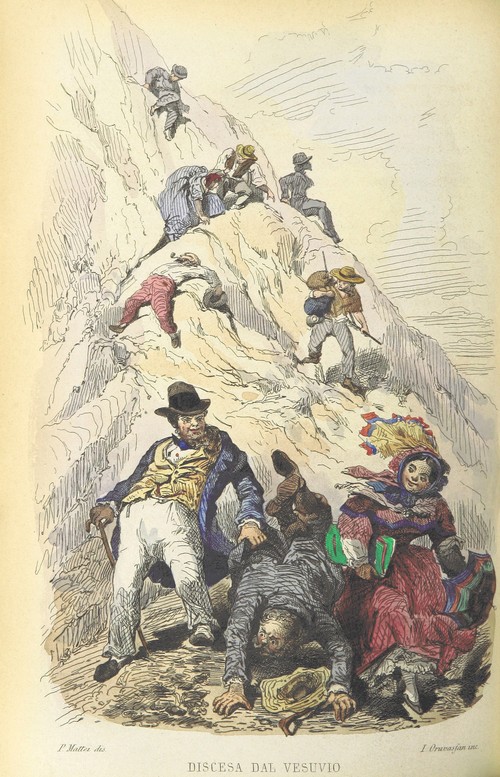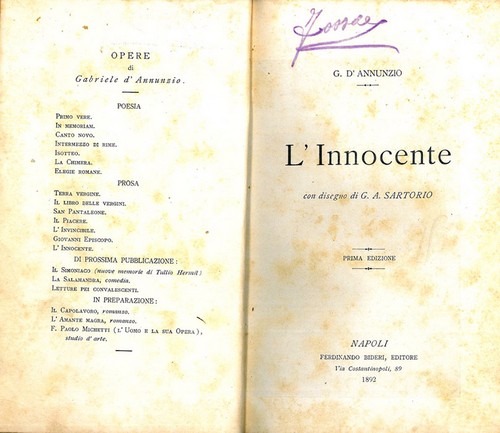vai alla pagina precedente
Mastriani: il primo
scrittore europeo di “gialli”
181. Or dunque: lo scrittore statunitense Edgar Allan
Poe (1809-1849) fa storia a sé; ma, per il romanzo
“Il mio cadavere”, del 1851, Mastriani è senz’altro da
considerarsi il primo scrittore europeo del
genere “giallo”, essendo il suo lavoro ben anteriore al
celebre “La pietra di luna” di Wilkie Collins
(1824-1889) che uscì nel 1868, ed ancor più al già
citato “Uno studio in rosso” di
Arthur Conan Doyle (1859-1930)
che è del 1887.
Angiolina e … Ginevra
182. Molto interessante è anche il romanzo “Angiolina o
la corìfea” (1857), soprattutto per il confronto, che
l’attento lettore potrà fare, con l’immeritatamente un
po’ più noto “Ginevra o l’orfana della Nunziata” di
Antonio Ranieri (1806-1888), il molto discusso
sodàle di Giacomo Leopardi.
Il Ranieri aveva pubblicato la sua “Ginevra” la prima
volta nel 1839, denunciando maltrattamenti ed abusi
presso il celebre ricovero per bambini abbandonati
“dell’Annunziata” in Napoli.
Ma egli era mediocre scrittore oltre che mediocrissimo
uomo, come poi meglio si vide con la pubblicazione dei
suoi “Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi”
(1880).
Per imperizia letteraria e malafede politica, esagerò
dunque in maniera finanche grottesca gli abusi e le
carenze pur realmente presenti alla Nunziata ed avvenne
semplicemente che l’allora Ministro dell’interno
Niccolò Santangelo, essendo
fratello del capo dell’amministrazione della Nunziata,
lo fece detenere in prigione per 45 giorni.
Ma il re Ferdinando II di
Borbone (anche in seguito alla intercessione del
presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Ceva
Grimaldi, che era ostile al Santangelo) lo fece liberare
ed assegnò 50 mila ducati in più di rendita alla
Nunziata e all’Albergo dei poveri, cambiandone anche
l’amministrazione, al fine di eliminare le carenze e gli
abusi realmente riscontrati.
|
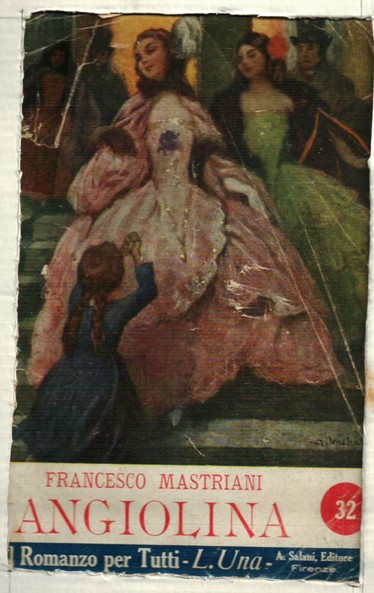 |
Angiolina nell'edizione Salàni |
183. Quegli “eroici” 45 giorni di carcere fecero però di
lui, dopo il 1860, una sorta di “martire” del
Risorgimento: egli, che era stato assai cautamente
liberale nel 1848 e figurava semplicemente fra i
notabili che si recarono a Grottammare per invitare
Vittorio Emanuele II ad invadere il Regno delle due
Sicilie “a nome del popolo napoletano”, si ebbe il posto
di deputato del Regno d’Italia per 20 anni (dal 1861 al
1881) e subito dopo di senatore fino alla morte
(1882-1888), nonché una cattedra di “Filosofia della
storia” presso l’Università di Napoli, per chiari meriti
solo politici.
184. Il Mastriani, con la sua “Angiolina”, a confronto
col Ranieri e la sua “Ginevra”, appare, a giudizio di
chi scrive, un gigante, sia come scrittore sia come
uomo.
Dopo il 1860: le sventure
di un non-sabàudo
185. Nel
settembre del 1860, Francesco Mastriani indossò, sia
pure per breve tempo, la divisa della Guardia Nazionale
cittadina, allora ristrutturata dal Ministro
dell’Interno Liborio Romano con l’intenzione di favorire
un “passaggio dei poteri”, il più possibile indolore,
tra Francesco II di Borbone, che usciva da Napoli per
tentare un’ultima resistenza nella fortezza di Gaeta, e
Garibaldi che era ormai prossimo ad entrarvi.
In quel
cruciale settembre, egli “respirò nell’aria”
l’entusiasmo e le speranze che l’ingresso di Garibaldi
in Napoli accese, non solo nella classe borghese
liberale ma anche in larghi strati del popolo minuto. Ma
anch’egli, come quasi tutti, ne rimase ben presto
deluso.
186. Dopo
l’occupazione sabauda nel 1860, e precisamente il
1°maggio 1862, cessò la pubblicazione del
Giornale del Regno delle due Sicilie
e Mastriani,
come gli altri redattori, fu dapprima collocato “in
aspettativa” con intero stipendio il 24 settembre 1862,
e l’anno dopo, con il Decreto N°1384 emesso da Torino il
19 luglio 1863, dichiarato “in disponibilità”.
Il 17 aprile
del 1865, rinunciò ai suoi diritti di “impiegato in
disponibilità”, in cambio della somma una tantum,
al netto di trattenute, di lire 1142,20 corrispondente
ad un’annata di stipendio.
187. Il fatto di aver collaborato con giornali
borbonici, e forse ancor più di aver riposto grandi, e
presto deluse, speranze in Garibaldi, gli procurò la
permanente diffidenza, ostilità e sotto-valutazione da
parte del nuovo potere sabàudo e della scuola liberale.
Il famoso storico della letteratura Francesco De Sanctis,
patriota italiano e Ministro della Pubblica Istruzione
nei primi governi post-unitari, non lo ritenne
meritevole di alcuna citazione nei suoi studi critici,
mentre definì lo scrittore Carlo Tito Dalbono (1817-1880),
suo compagno di partito, il “più napoletano de’ Napoletani,
come fu detto di Palmerston che era il più inglese
degl’Inglesi”
[71].
In realtà, il Dalbono, oltre che uomo politico,
giornalista, critico d’arte, autore di drammi e di guide
turistiche, fu scrittore di insipidi e sin troppo
fantasiosi “romanzi storici”, confusamente ispirati a
storie e leggende popolari napoletane, senza in realtà
essere “né storico né romanziere” (Federico Verdinois).
In ogni caso, è un fatto che i suoi romanzi, già pochi
anni dopo la sua morte, non li leggeva più nessuno,
mentre quelli di Mastriani diventavano sempre più
popolari.
I grandi romanzi degli anni Sessanta
188. Negli anni Sessanta, a dispense sui giornali ed in
volume, il Nostro pubblicò la sua celebre trilogia:
1)
I VERMI - Studi storici sulle classi pericolose in
Napoli – Tipografia di Luigi Gargiulo, Strada
Speranzella n°95, Napoli, 1863.
2)
LE OMBRE - Lavoro e miseria – Romanzo storico-sociale -
Tipografia di Luigi Gargiulo, Strada Speranzella n°95,
Napoli, 1868.
3)
I MISTERI DI NAPOLI - Studi storico-sociali -
Stabilimento tipografico del Comm. G. Nobile, Vicoletto
Salita a’ Ventaglieri n°14, Napoli, 1869.
I vermi: il titolo
189. Il Mastriani stesso spiega il titolo dell’opera,
con le seguenti parole:
“Come il marciume, la sordidezza (= sporcizia) e
la morte producono i vermi nel mondo fisico, così
l’OZIO, la MISERIA e l’IGNORANZA producono i loro
vermi nel mondo morale … i miserabili sono
gli appestati della società perciocché sono quelli
appunto che più portano scoverta la piaga che li rode;
mentre gli oziosi gittano su la loro cangrena le
essenze più prelibate e odorose; e gli ignoranti
la coprono con una fascia d’oro o di seta”.
I vermi: lo scopo
190. Egli spiega poi anche lo scopo “utile e morale” che
il suo libro si propone:
“Illuminar quindi, per quanto è possibile, il povero
onesto, la innocente figlia del popolo e il giovin
signore su gli agguati che lor tendono
incessantemente quelli che speculano su l’ozio,
su la miseria e su l’ignoranza, ci sembra
opera santa, quali si vogliano i mezzi che a ciò
s’impieghino ...
La nostra speranza è che (questo libro) sia letto
e propagato fra le classi medesime di cui ci occupiamo,
e verso le quali non abbiamo che un sentimento di
profonda commiserazione e un desiderio vivissimo di
cooperare al salutare ritorno di qualcuno di questi
miseri nel seno degli onesti, e nelle ordinarie
condizioni della vita sociale, da cui si trovano oggidì
segregati ed espulsi”.
I vermi: lo stile
191. Infine, il Mastriani ci spiega anche il suo stile
letterario di “fotografismo topografico” (Luca Torre):
fatti veri, particolari esattissimi,
luoghi visti anzi studiati da vicino, personaggi
realmente esistenti:
“I fatti su cui si appoggiano i nostri studi storici
sono, la maggior parte, veri: i particolari che diamo
sui costumi, su le pratiche, sul linguaggio di queste
classi sono esattissimi, perciocché, vincendo la
ripugnanza che c’ispiravano i luoghi più abbietti,
abbiam voluto studiarli da vicino, per offerirne un
quadro sincero, comeché sempre velato da quel santo
pudore che le lettere non debbono mai abbandonare. I
personaggi che figurano in questi nostri racconti sono
la maggior parte esistenti …”
|
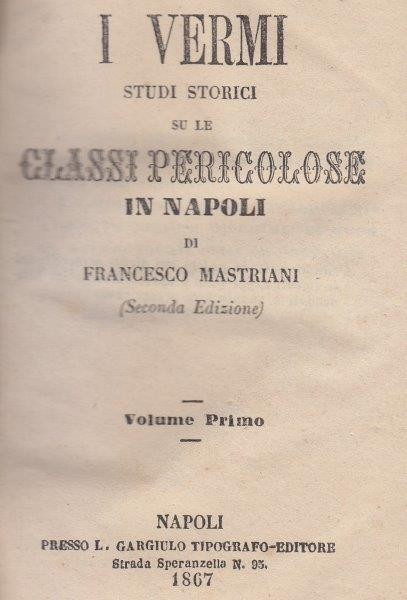 |
I vermi di Francesco Mastriani |
I vermi: lo schema
192. Il libro si articola dunque, con chiaro intento
istruttivo, nelle 3 “piaghe” dell’ozio, della miseria e
dell’ignoranza, più una conclusione, secondo la schema
seguente:
PRIMA PIAGA: L’OZIO
-
Parte prima: La camorra elegante
(I - A Posillipo; II – Madama Antonetta; III –
Blandina; IV - Le farfallette; V - La trìbade; VI –
Carolina; VII - La lotta; VIII - La vittoria).
-
Parte seconda: I vagabondi
(I – Il tempo e la potestà paterna; II - Le tarle;
III - Dio non paga il sabato).
-
Parte terza: I lavori forzati
(I – Il bagno di Nisida; II - Stefano Merli).
SECONDA PIAGA: LA MISERIA
-
Parte prima: Gli accattoni
(Preliminari; I - Francesco Loiodice; II - Il
letterato; III - Il figlio dell’esule; IV - La fossa
dei poveri; V - L’improba mendicità).
-
Parte seconda: Falsi mestieri e domestici
-
Parte terza: La prostituzione
(Preliminari; I - Lucia; II - Le case infami; III -
La prima notte; IV - La casina francese; V - Il
peccato dell’impurità; VI - La moglie e la druda;
VII - La madre; VIII - La riabilitazione; Riepilogo;
Il sifilicomio in Napoli).
TERZA PIAGA: L’IGNORANZA
CONCLUSIONE
Ma non come Victor Hugo!
193. “Noi avevamo concepita quest’opera molto innanzi
che fosse venuto a luce il libro stupendo de'
Miserabili di Vittor Hugo. Confessiamo che la
lettura di questo ammirabile lavoro del romanziero
francese ci avrebbe scoraggiati dallo intraprendere il
nostro, qualora non ci fossimo avveduti della
differenza della indole dell’opera, differenza
che i nostri lettori rileveranno di per sé, dove
attentamente si facciano a leggerci.
Nel resto, non bisogna mai diffidare delle proprie forze
quando si ha in vista, non un titolo di vanagloria, ma
uno scopo utile e morale, e il bene de’ propri
concittadini”.
Le ombre: lavoro e
miseria
194. “Dopo I vermi scrissi I figli del lusso,
farfalle sociali che nascondono sotto le loro ali
screziate il bruco schifoso.
E poco di poi, scrissi Le ombre in cui, svolgendo
la vita dell’operaia nella sua triplice elegia di
Orfana, Moglie e Madre, toccai di quella enorme
ingiustizia sociale quale è il lavoro donnesco …”
195. Tuttavia, il libro per il quale ancor oggi
Mastriani è più conosciuto è il celebre “I misteri di
Napoli”, del 1869, al cui riguardo, però, del tutto
ingiustificati pregiudizi hanno fatto accumulare varie
inesattezze, a dissipar le quali non v’è cosa migliore
che lasciare la parola allo stesso Mastriani …
|
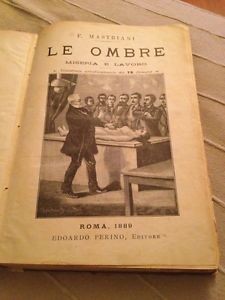 |
Le ombre di Francesco Mastriani |
I misteri di Napoli
secondo Mastriani
196. “Gran tempo innanzi di scrivere “I vermi”, “I figli
del lusso” e “Le ombre”, avevo divisato di pormi alla
presente opera ma non poche ragioni mi dissuasero allora
di mettervi mano …
197. Erano recentemente venuti a luce (1843) “I misteri
di Parigi” del Sue, opera che aveva cattivato le
simpatie di tutta Europa e che, in piccolo spazio di
tempo, ebbe l’onore di numerose ristampe e traduzioni.
La smania di imitare le cose francesi, funesta debolezza
in Europa tutta e massime in Italia, fe’ piovere
misteri da tutte le parti.
Ogni paesello, ogni borgata, ebbe un Eugenio Sue, tanto
che i misteri vennero in parodia… insomma, la
maggior parte de’ romanzieri si dettero a scavare nelle
fogne della società per mettere in evidenza tutto ciò
che, ne’ diversi centri di civili popolazioni, è di più
laido e nefando.
198. Aborrente, per principio e per gusto, da tutte le
grette imitazioni e segnatamente dalle novità che ci
vengono da’ nostri vicini di oltralpe, tenni fermo, per
non breve spazio di tempo, a non voler apporre il titolo
di Misteri di Napoli a nessuna delle mie opere …
Dàtomi, per naturale propensione e per gusto, alla
sintesi psicologica delle diverse classi che compongono
il civile consorzio, volli attentamente studiare da
vicino quella gran sezione degli abitanti d’un vasto
centro di popolazione i quali danno il maggior
contingente agli sgabelli infami delle Corti di Assise.
Scrissi “I vermi” e quindi “I figli del lusso” … e poco
di poi scrissi “Le ombre” …
199. Ora, mi si conceda di dire qualche cosa intorno
allo scopo che mi prefissi in questo mio nuovo lavoro …
Dove io avessi ripescato nel fango della nostra società,
non avrei fatto altro che ripetere, sotto altra forma,
le brutture da me descritte ne' Vermi e nelle
Ombre: il mio libro non sarebbe stato che una
pallida imitazione d’una mia stessa opera o di altre di
simile stampo. Ho voluto invece seguire un cammino
affatto opposto.
Ed a far pienamente intendere il mio concetto, è d’uopo
che io tocchi brevemente di alcuni speciali caratteri
de’ tempi nostri e di noi altri meridionali in
particolare.
Alcuni speciali caratteri
de’ tempi nostri
200. Noi manchiamo di convinzioni e di princìpi: è
questo il più spiccato carattere della presente
generazione. Tutto assorti negli interessi materiali,
noi sfuggiamo di occuparci di noi stessi; e fine
supremo della vita poniamo il godimento materiale
dell’oggi.
E, gittàti al di fuori di questi materiali interessi,
noi non abbiamo nessuna fede, senza peraltro essere
perfettamente increduli; non abbiamo nessun saldo
convincimento, e sia pure un errore, un paradosso.
Diciamo di credere alla esistenza di Dio, ma la
nostra adorazione è tutta pel vitello d'oro. Non
siamo atei, non siamo scettici, non siamo credenti, non
siamo niente.
In quanto alla immortalità dell'anima, ai futuri destini
dell'uomo, tutto ciò non ci riguarda; il to be or not
to be (essere o non essere) ci è del tutto
indifferente. Non osiamo apertamente dire che la fede
nell'altra vita è una mera fandonia; ma ce ne ridiamo
sotto i baffi.
Le contraddizioni dei
nostri giorni
201. Da questa mancanza di convinzioni di ogni sorta
derivano le più strane e curiose contraddizioni che si
osservano a’ dì nostri:
noi confondiamo la libertà di coscienza con l’assoluto
indifferentismo su qualsivoglia credenza religiosa;
vogliamo l'indipendenza e la libertà, e non apprezziamo
che ciò che è francese, inglese o giapponese, e non
sappiamo perdonare al nostro vicino di avere una
opinione contraria alla nostra;
vogliamo l'eguaglianza civile, e non ci vergogniamo di
farci dare l'eccellenza da’ nostri servi;
gridiamo al mal governo, e non ci vogliamo prendere
l'incomodo di andare a porre una scheda nell'urna;
predichiamo filantropia, e diamo croci e premi a chi
inventa un modo novello di distruzione più pronta e più
sicura, mentre lasciamo crepare di fame la virtù e
l'ingegno;
diciamo di essere uomini positivi, e paghiamo 10.000
lire al mese a qualche saltatrice (= ballerina,
soubrettina) più o meno in grido;
facciamo arrestare i ladruncoli di fazzoletti, e
lasciamo andare a seggi governativi quelli che rubano i
milioni;
vogliamo più o meno l'emancipazione della donna, e per
poco non diamo la berlina a una povera signora che
cammini sola per le strade;
insomma … ci crediamo uomini, e non siamo che
scimmie.
202. Questa mancanza di princìpi e di convinzioni fa sì
che noi manchiamo eziandio di fermezza nei nostri
propositi, di dignità personale e di rispetto di noi
stessi.
Sempre servilmente ossequienti al potere ed alla forza,
ci contentiamo di sparlarne in segreto, balestrando
un’occhiata paurosa all’intorno per tèma di essere
intesi; non dissimili in questo dai valletti che seggono
oziosi nelle anticamere del loro padroni e che si
disfogano a maledirli, salvo a correre a baciar loro le
mani non appena li vèggano apparire in su la soglia.
La borghesia affarista
203. Dall’un canto, le classi intelligenti, educate, ed
anco istrutte, son magagnate dal tarlo della
società presente che con novello vocabolo si è nominato
affarismo: tarlo micidiale dell’anima, roditore
di ogni nobile aspirazione morale, lento ma efficace
distruttore di ogni principio di equità, di umana
fratellanza e della divina voce della carità.
La plebe scioperata
204. Da un altro canto, una sterminata classe di
scioperati, che abborrono la fatica, e che per vivere, o
per alimentare i loro vizi, debbono risolvere ogni
giorno l'arduo problema di carpire una polizzetta da 5
lire dalla tasca dei loro amatissimi fratelli in Adamo,
senza pertanto sfregarsi colle autorità di Pubblica
Sicurezza.
I governi … civili?
205. I governi civili, che schiudono carceri e all’uopo
innalzano patiboli per colpire i reati contro la
proprietà e la vita, non hanno saputo ancora trovare
un premio alla virtù…
206. Ma che dico. I governi sanno pure trovare un
premio per la più sfacciata immoralità, per la
mezzanità proterva e boriosa, per la raffinata
ipocrisia, per la codarda ed abbietta cortigianeria.
Vistosi emolumenti, alti uffizi, ciondoli e croci
piovono addosso a gente immorale, ignorante, proterva,
strisciante, vituperevole.
Siamo ogni dì contristati dallo scoraggiante spettacolo
d’impieghi ottenuti per la impudicizia di donne
disonorate, per la vergognosa condiscendenza di abbietti
mariti, e non poche volte pel sacrificio di caste ed
innocenti donzelle.
Ci nausea la vista perpetua di eleganti camorristi
accolti e festeggiati nelle case patrizie e
sfacciatamente sfolgoranti di un lusso, la cui origine
dovrebbe fare arrossire il codice penale.
207. Intanto, che cosa fanno i governi civili a pro
dell'ingegno e della virtù? Colpiscono il ladro, se
ha la malaccortezza di farsi ghermire nel momento che
mette la mano nell’altrui tasca per rubare il
portafogli, l'oriuolo o il moccichino; ma gli appiccano
un ciondolo al petto, se ha l'abilità di deviare
un milione.
E per la virtù, che si lascia trangosciare di stenti e
si astiene, che cosa fate, o signori delle aule
governative?
Ed alla vecchiezza dell’onesto operaio, che ha vissuto
illibatissima vita, qual riposo assicurate voi?
L'ospizio de’ poveri o l’ospedale! Ed alla vedova ed
agli orfani di quell’integerrimo padre di famiglia, che
abbreviò la vita per sostenere la moglie e i figliuoli,
quale sorte serbate? Alla vedova, il pane della privata
carità; ai figliuoli maschi, il supplizio del servizio
militare; alle femmine, il postribolo.
I mali che travagliano
l’Italia
208. Abbiamo in Italia la spaventevole cifra di 16
milioni di analfabeti, di cui, per carità del
suolo nativo, non dirò quanta parte spetta alla nostra
Napoli. Migliaia e migliaia di cretini vegetano
in alcune vallate delle Alpi e dell'Appennino; i quali
non hanno dell'uomo che il beffardo ironico nome. Altri
migliaia e migliaia languiscono di febbri perpetue
prodotte dalla malaria, dallo scarso e malsano
nutrimento, dalle estenuanti fatiche, dalle protratte
vigilie.
209. Né vale il dire che anche altrove questi mali
travagliano le popolazioni. Altrove, è colpa della terra
e del clima; appo noi, è colpa dell'uomo.
Egli è certo che la vita in Italia è più breve che
altrove: vergognoso oltraggio alla Provvidenza che ci
largì tutt’i tesori della sua inesauribile benevolenza!
Laddove le altre nazioni, meno favorite di noi, studiano
i mezzi di accrescere il loro benessere e la loro civile
e morale perfezione, noi studiamo i mezzi di renderci
frustànei (= inutili, vani, infruttuosi) i doni
del cielo.
Ingegni sublimi ci lasciarono pagine immortali, tesori
di scienza e di ben vivere sociale; e noi, poscia di
aver lasciato morir d’inedia que’ sublimi ingegni nel
tempo in che furono in mezzo a noi, oggidì ci teniamo
paghi di far pompa de’ loro volumi in su i palchetti
delle nostre librerie.
I misteri di Napoli sono
i misteri della virtù
210. Premesse queste cose per le generali, additerò
brevemente quale è lo scopo del mio lavoro.
Occulti fatti si compiono nel seno delle popolose città.
I grandi delitti, le opere inique, i luttuosi
avvenimenti, sono rivelati dalle cronache della stampa
periodica: i lettori ricercano con avidità questo pasto
giornaliero della loro curiosità.
Ma vi è una categoria di fatti che non hanno altro
testimone che l'occhio di Dio, fatti che onorano la
specie umana …
Il CONTAGIO DEL VIZIO, che è una delle più grandi piaghe
delle popolose città, troverebbe efficace correttivo
nello ESEMPIO DEL BENE, dove la stampa si occupasse a
ricercare i misteri della virtù con lo stesso
ardore onde si occupa a ricercare e rivelare i turpi
fatti del vizio.
“I Misteri di Napoli” saranno dunque la rivelazione
degli occulti splendori dell’anima sofferente nelle
torture sociali.
|
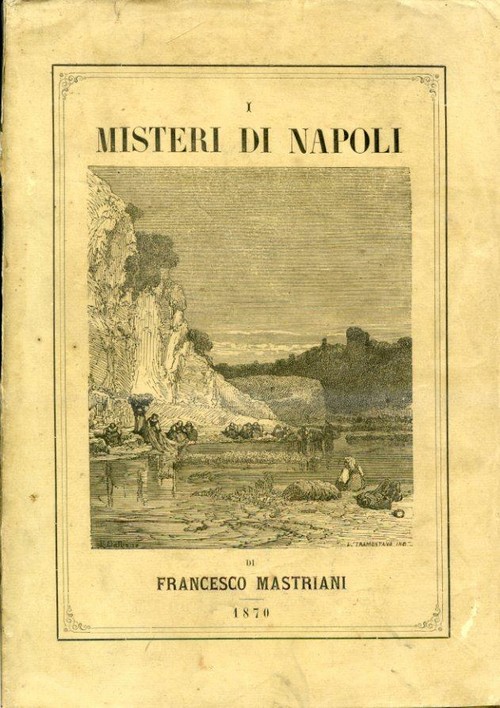 |
I misteri di Napoli di Francesco Mastriani |
Il male: opera di Dio o
dell’uomo?
211. Un fatto costante e terribile sembra, agli occhi
degli stolti, che faccia brutta dissonanza nell’ordine
maraviglioso della creazione: l’esistenza del male.
Questa quistione, non risoluta o mal risoluta, ha
portato l'uomo al dubbio, allo scetticismo: è essa che
crea gli atei, gli empi e i semi-credenti.
212. Ma è forse Iddio che ha creato il male? È forse
colpa dell’Artefice se una mano inesperta guasta
l'accordo della macchina, per proterva o stolta voglia
di correggerla?
Il Supremo Artefice (dice l'insipiente) non doveva
esporre l'opera sua ad essere guasta dall'uomo. E noi
rispondiamo:- La guastano forse gli animali che popolano
la terra? E vi sareste voi contentati di agguagliarvi
alla condizione degli animali? Volete sconoscere la
bontà di Dio, che vi creò Sua
immagine,
dotandovi del sublime dono della Ragione e del
Libero Arbitrio?
213. Il male è dunque incontrastabilmente l'opera
dell'Uomo. Da millenni, ei si travaglia a rendersi
felice, e non può: l’Ignoranza vi si oppone.
Ciò non pertanto, il raggio divino della Intelligenza
superò gli ostacoli infiniti che l’Ignoranza le
gittava tra’ piedi, e fece a palmo a palmo maravigliose
conquiste sul paradiso perduto. Caddero l’un dopo
l'altro gli sterminati massi che la tirannide dei
potenti, coadiuvata dalla tirannide sacerdotale, avea
innalzati a puntello di un esoso edificio di usurpazioni
e di arbitrii.
214. Quando l'orgogliosa potenza romana parea che
volesse soffocare le immortali tradizioni dell’umana
grandezza nello sfacelo d’ogni principio morale, il
VERBO DI DIO UMANATO rialzò la creatura, promulgando un
codice divino di giustizia, di fraternità, di amore.
Ma la gran legge di amore fu affogata dalla nequizia
delle tristi passioni, dalle smodate ambizioni, dall’obblio
dei grandiosi destini dell'anima.
I re, i preti, i ricchi, i potenti
elevarono altri codici informi su quello predicato dal
Cristo.
La schiavitù, il feudalismo, la proprietà illimitata, il
monopolio delle coscienze e de’ beni della terra, gli
eserciti permanenti, la gleba muliebre, snaturamento
della donna, gli omicidi giuridici, le guerre, ed altre
moltissime di queste sociali cangrène, travagliarono e
travagliano ancora l’inferma società tra spire
torturanti.
215. Ma Iddio trasse il bene dal seno stesso del male.
Migliaia di martiri della virtù e dell'amore formano
ogni dì la più splendida protesta contro la mala
organizzazione sociale. Questa nube di anime che vola al
cielo, gemente ancora delle sofferenze della vita,
affretta ogni dì il compimento de’ nobili destini
dell'uomo.
216. Questa opera (“I Misteri di Napoli”) avrà
dunque lo scopo di additare la virtù, cozzante co’ vizi
della presente società e co’ mali inseparabili dai
presenti ordinamenti sociali.
E’ storica la tela del mio racconto? Sono veri i
personaggi di questo gran dramma? A questi quesiti non
risponderò che una sola parola: LEGGETEMI”.
Considerazioni
riassuntive su Francesco Mastriani
217. Come si vede, dunque, “I misteri di Napoli” hanno
proprio nulla a che spartire con “I Misteri di Parigi”
di Eugenio Sue.
Mastriani non è certo l’equivalente di ciò che oggi
sarebbe un autore di tele-novelas, né la sua
opera narrativa può minimamente essere confusa, come a
volta accade, con la “sceneggiata napoletana” che fu
invece, nel bene e nel male, “inventata” solo nel 1919:
in forma teatrale, dall’impiegato postale Enzo Lucio
Murolo; ed in forma cinematografica, da Emanuele
Rotondo, fondatore della “Miramare film”.
218. Francesco Mastriani, dal canto suo, non si propone
di “scavare nelle fogne della società, per mettere in
evidenza tutto ciò che, ne’ diversi centri di civili
popolazioni, è di più laido e nefando”, a pro di
quei “lettori che ricercano con avidità questo pasto
giornaliero della loro curiosità”, magari contribuendo,
così, al “contagio del vizio”.
Vuole, invece, “additare la virtù”, che si manifesta
proprio nelle circostanze più difficili, affinché
“l’esempio del bene” possa contribuire a migliorare i
“presenti ordinamenti sociali” e ad “affrettare ogni dì
il compimento de’ nobili destini dell'uomo”.
219. I suoi, più che romanzi, sono “studi
storico-sociali” (vedi sopra, n°188), saldamente fondati
su:
- una precisa analisi della società del suo tempo
(vedi sopra, nn°200-209): analisi che è, per molti
aspetti, ancora attuale;
- una riflessione filosofica che, rifacendosi
chiaramente a Pasquale Galluppi, si pone le grandi
questioni metafisiche come l’esistenza di Dio,
l’immortalità dell’anima, la giustizia ultra-terrena, e
l’origine del male nel mondo; e addirittura, in alcuni
punti, come sempre accade nei sinceri credenti, tocca
finanche le vette della intuizione mistica (vedi
sopra, nn°210 e 215; e confronta: La Bibbia – Apocalisse
6, 9-11).
Cultura e ideologia a
Napoli dopo la conquista sabàuda
220. Dopo aver ragionato sulle
classi sociali a Napoli dopo la conquista sabàuda (vedi
sopra n°102 e segg.), tratteremo ora della coeva
super-struttura culturale.
Accenneremo perciò brevemente,
nel seguito, all’alta cultura di èlite, al
teatro e alla caratteristica produzione musicale.
Hegel a Napoli? …
Nun è cosa!
221. Subito dopo l’unificazione
politica della penisola, un piccolo gruppo di
intellettuali, soprattutto professori universitari
meridionali, si illuse che la filosofia di Hegel potesse
diventare la “religione civile” della nuova Italia[72].
Ma l’illusione durò poco e non
sopravvisse ai vari Betrando Spaventa, Augusto Vera,
Antonio Tari, Donato Jaja, etc. i quali, dopo la morte,
furono quasi tutti rimpiazzati in cattedra da filosofi
appartenenti alla nuova e “più moderna” scuola
positivista.
|
 |
Hegel (1770 - 1831) nel suo studio |
222. A quanto pare, dunque, la
filosofia di Hegel risultò, agli occhi dei “nuovi
italiani”, talmente astrusa ed astratta da prestarsi
assai poco allo scopo desiderato da quei professori.
Nel nostro Meridione, in
particolare, tutto ciò che accadde fu che alcuni giovani
delle province, appartenenti all’aristocrazia o all’alta
borghesia agraria, venuti a Napoli a studiare
all’Università, riuscirono faticosamente a laurearsi
sulle sudatissime traduzioni dei testi hegeliani
effettuate dai docenti con i quali dovevano sostenere
l’esame.
Tornati al loro paese,
conservarono gelosamente nelle loro biblioteche i libri
sui quali avevano studiato in gioventù e scandalizzarono
i loro contadini e loro pie consorti perché si
rifiutavano di partecipare alla Messa e alle processioni
paesane.
Io so’ nu fesso (senza ‘o
begriff)
223. Ma, già fra gli studenti
universitari, quelli che potevano cercavano di stare
alla larga dai begriffe.
“Il culto del filosofo di
Stoccarda, racconta Adriano Tilgher, si è talmente
diffuso a Napoli che il suo Begriff (= Idea,
Concetto) è entrato addirittura come locuzione
proverbiale nel gergo degli studenti, i quali chiamano
‘e begriffe i suoi seguaci.
Popolarissimo, fra loro, è il
professor Donato Jaja (che fu anche il maestro di
Giovanni Gentile) il quale un giorno, passeggiando
in compagnia di un discepolo, s’infiamma a tal punto
della grandezza concettuale di Hegel da mettersi a
urlare:- Il begriff è tutto! Il begriff è
beltà, è bontà, è verità! Fuori del begriff non
esiste nulla! Senza il begriff, chi sono io che
parlo? Un’ombra, un fiato di voce, un niente … io sono
un fesso!”[73].
Un fesso no, ma un ciarlatano si
224. Del resto, era stato proprio un altro filosofo
tedesco, suo contemporaneo e rivale, e cioè Arthur
Schopenauer (1788-1860) a definire lo stesso Hegel,
senza tanti complimenti, non precisamente “un fesso” ma
“un ciarlatano di mente ottusa, insipido, nauseabondo,
illetterato, che raggiunse il colmo dell'audacia
scarabocchiando e scodellando i più pazzi e mistificati
non-sensi …
Se
si volesse instupidire un giovane, basterebbe fargli
leggere le opere di Hegel per renderlo completamente
inetto a pensare … Non bisogna far altro che dargli in
mano un libro di Hegel e quando quello leggerà che …
l’essere è il nulla … l’infinito è il finito … il
generale è il particolare … la storia è un
sillogismo … finirà con l'andare all'ospedale dei
pazzi!”[74].
|
 |
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860) |
Chi ha letto Hegel?
225. “E’ un segreto di Pulcinella il fatto che nessun
interprete di Hegel sia in grado di spiegare, parola per
parola, una sola pagina dei suoi scritti” (Theodor
Haering), i quali sono comunemente ritenuti, da docenti
e studenti di filosofia, fra i più criptici ed oscuri,
insieme a quelli di Fichte e Schelling.
Si
può serenamente ritenere che gran parte di coloro che
hanno “spiegato” Hegel ex-cathedra, professori
universitari o di scuole superiori, hanno semplicemente
ripetuto ai loro allievi, in modo più o meno brillante,
la sintesi riportata nei manuali, senza mai aver letto
per intero un capitolo testuale di Hegel.
|
 |
Schopenhauer ed Hegel insegnavano nella stessa
Università |
226. In ogni caso, nelle sue luci e nelle sue ombre,
orali o scritte, l’influenza dell’hegelismo sulla
mentalità delle grandi masse popolari fu praticamente
nulla.
Nello stesso ambiente accademico napoletano, abbiamo
visto Antonio Labriola passare, assai presto,
dall’hegelismo
al
marxismo[75].
Ma anche i due massimi teorici
della borghesia italiana nella prima metà del Novecento,
il liberale Croce ed il fascista Gentile, poterono
professarsi discepoli di Hegel solo dopo averlo
ampiamente “riveduto
e corretto” e, ognuno a suo modo, avvolto in più
“mediterranei” indumenti.
Si potrebbe dire che, se
Labriola aveva fatto fare “a Marx il bagno nel golfo di
Napoli”
[76],
Croce e Gentile fecero fare “il
bagno nel golfo di Napoli” a Hegel, anche se in due
punti diversi della spiaggia …
A teatro: la
“fucilazione” di Pulcinella
227. “Tra le vittime del
processo di unificazione al Sud, la più illustre e
certamente innocente fu la maschera di Pulcinella. Cadde
sotto il piombo dei caratteri usati dal grande patriota
e letterato Francesco De Sanctis e dal suo giovane
allievo Giorgio Arcoleo.
In un saggio intitolato non a
caso Pulcinella dentro e fuori il teatro, la
maschera bianca dal volto nero diventava l’espressione
del plebeo lazzarone devoto al Borbone, che andava
quindi epurato nella Napoli italiana conquistata
alla libertà.
Passava qualche anno
dall’articolo di Arcoleo sulla Nuova Antologia e
moriva Antonio Petito (1822-1876), l’ultimo
grande Pulcinella del teatro San Carlino, sito di fronte
al Maschio Angioino”[77].
|
 |
Antonio Petito (1822-1876) |
A teatro: Edoardo
Scarpetta
228. “Cominciava il tempo di
Eduardo Scarpetta (1853-1925) e del suo nuovo
personaggio, il piccolo borghese, abbastanza illetterato
e ridicolo, don Felice Sciosciammocca”[78].
Scarpetta debutterà, come
impresario oltre che attore, al San Carlino nel 1880. Le
sue opere più originali sono Miseria e nobiltà (1888)
e ‘O miédeco d’e pazze (1908). Ma il suo teatro
comico, inclusi i lavori più noti, come ‘O
scarfalietto (1881), ‘Nu turco napulitano (1888),
‘Na santarella (1889), è quasi tutto una semplice
anche se intelligente traduzione dal francese, che
serviva a raccogliere applausi e quattrini da un
contegnoso pubblico piccolo-borghese che voleva soltanto
divertirsi senza usare troppo il cervello.
|
 |
Eduardo Scarpetta (1853-1925) |
La città della musica
229. Napoli, si sa, è ab antiquo la capitale
della musica: “se,
nelle altre belle arti, vari paesi d'Italia possono
pretendere il primato, nella musica nessuno può
contendere con Napoli”[79].
Addirittura, lo storico romano
Svetonio racconta che perfino l’imperatore Nerone volle
venire a Napoli per essere acclamato, nei teatri
cittadini e presso la grotta di Pozzuoli, come grande
“cantautore” dell’epoca.
230. “La nostra scuola musicale moderna fu stabilita nel
XV secolo da Ferdinando I di Aragona, sotto la direzione
di Garnerio e di Gafforio, i quali pubblicarono a Napoli
le prime opere sulla musica. Altre opere poi sullo
stesso subbietto furon pubblicate nel principio del
secolo XVII da Pietro Ceroni, che facilitò le regole
musicali de’ tre collegi di musica che allora esistevano
e che poi vennero nel XIX riuniti in uno”[80].
E’ a Napoli che nacquero,
infatti, i “Conservatori”: originariamente istituti di
beneficenza per accogliere orfani ai quali veniva
insegnata la musica, divennero così le prime “scuole di
musica” in Europa.
Al loro sorgere, nel
Cinquecento, i Conservatori erano in effetti quattro;
durante il Decennio francese, nel 1806, il re Giuseppe
Bonaparte li unificò nel “Real Collegio di Musica”, che
20 anni dopo Francesco I di Borbone spostò nella attuale
sede di S. Pietro a Majella, come ricorda la targa posta
all’ingresso dell’edificio:
“Questo antico edificio, già venerabile convento dei
Padri celestini di San Pietro a Majella, nel 1826 per
volontà di Francesco I, Re delle Due Sicilie, fu
destinato ad accogliere la gloriosa scuola napoletana ed
a conservare le preziose testimonianze degli antichi
conservatori dei Poveri di Gesù Cristo (fondato nel
1589), Santa Maria di Loreto (1535),
Sant'Onofrio a Capuana (1578), Pietà dei
Turchini” (1573).
231. Nel Settecento, abbiamo
già ascoltato Benedetto Croce celebrare la musica come
le triomphe des napolitaines
[81].
In quel tempo, l’opera buffa
riceveva a Napoli il suo battesimo, con autori come
Cimarosa, Piccinni, Pergolesi, Paisiello; ed il
melodramma, nato a Firenze presso i Bardi e divenuto
popolare a Venezia grazie a Claudio Monteverdi, assumeva
proprio a Napoli quella forma che si chiamerà poi
tipicamente “italiana”.
232. Tempio della lirica era
naturalmente il “S. Carlo”, affiancato però dal
“Fiorentini” dal “Fondo” e dal “Nuovo”. Nella prima metà
dell’Ottocento, tutti e quattro erano gestiti da
Domenico Barbàja (1777-1841), un sagàce impresario
milanese, venuto dal popolo (era stato garzone di bar e
poi tenutario di bische), senza molta istruzione ma con
un grande fiuto artistico oltre che per gli affari: sarà
lui a convocare a Napoli cantanti come Isabella Colbran
(di cui fu anche l’amante), Manuel Garcia e Maria
Malibran e ad offrire attraenti contratti a musicisti
come Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Gioacchino
Rossini.
Un’opera data al “S. Carlo” o
al “Fondo” era sociologicamente l’equivalente di ciò che
oggi è una partita di calcio: metteva a soqquadro la
città prima e dopo; per settimane non si parlava
d’altro; tutti ne erano, o presumevano di esserne,
intenditori; e i motivi delle opere venivano ripetuti e
fischiettati per le strade dal popolo.
|
 |
L'impresario Domenico Barbaja |
233. Vi erano certamente anche
“poeti popolari”. Un viaggiatore francese della prima
metà dell’Ottocento, lo scrittore Alphonse de
Lamartine (1790-1869), parla dei “versi recitati dai
poeti estemporanei di Napoli, la domenica sera, ai
marinai, sul molo o a Mergellina”[82].
E quando lui ed un suo amico
dicono di essere anche loro dei poeti, la procidana
Graziella risponde con la sua descrizione di cosa si
intendeva allora a Napoli per “poeta”:
“Vi burlate di noi - diceva
Graziella scoppiando in una risata – Voi, dei poeti? Non
avete i capelli arruffati e gli occhi spiritati di
quella gente che lungo la marina vengono chiamati con
questo nome! Voi, dei poeti? E non sapete neppure
suonare due note con la chitarra! Con che cosa
accompagnate le vostre canzoni?”[83].
|
 |
Alphonse de Lamartine (1790-1869) |
234. Nei salotti aristocratici
e borghesi veniva invece eseguita musica da camera: le
signorine da marito, al pianoforte, si cimentavano con
sonate di Chopin o di Schumann, e le più talentuose
anche col canto.
|
 |
La celebre soprano Isabella Colbran (1784-1845),
amante di Barbaja e prima moglie di Rossini |
Le case editrici musicali
nel periodo borbonico
235. In questo contesto, è
abbastanza ovvio che, nella Napoli borbonica, fiorisse
una rete abbastanza vasta di “Case editrici musicali”
ovvero preposte a stampare i libretti d’opera e “le
carte di musica” (quelle che, notoriamente, secondo un
popolare proverbio, non potevano andare “in mano ai
cocchieri in affitto”).
Fra queste, si segnala, già dal
1817, quella fondata da Emmanuele Bidèr-a (che
poi diventerà Bidèr-i), un barone siciliano di
origini albanesi, e successivamente ereditata da suo
figlio Pietro Atanasio.
236. Alcune di queste case
editrici iniziarono però a svolgere anche un’altra
parallela attività: “Per conto di abili editori, ai
primi dell’Ottocento, alcuni musicisti andavano in giro
per i vicoli e le campagne, a trascrivere versi e
melodie ancora vivi nella tradizione popolare … salvando
così un prezioso patrimonio culturale, che altrimenti
sarebbe andato perduto per sempre”[84].
Girard, Cottrau, Azzolino,
Paolella
237. I francesi conquistarono
Napoli per un decennio (1805-1815); Napoli, però,
conquistò per tutta la vita Bernardo Girard e
Guglielmo Cottrau (1797-1847) i quali, giunti in
città al seguito dell’esercito napoleonico, ne rimasero
talmente affascinati da decidere di rimanervi anche
quando il Regno tornò ai Borbone.
Nel 1809, fondarono una casa
editrice musicale, che rimase poi al solo Cottrau, e che
fin dall’inizio svolse un’intensa opera di recupero e
trascrizione di canti popolari.
238. Solo di poco posteriore è
l’analoga casa editrice fondata dal tipografo
Francesco Azzolino, con bottega in Via Gerolomini,
della quale ci rimane anche un sommario bilancio
economico: all’autore (o a colui che “arrangiava” una
canzone popolare anonima) Azzolino versava 6 carlini, e
donava 1000 copielle stampate della canzone; le
altre copielle le affidava ad abili venditori
ambulanti che, strillandone il titolo come se fossero
angùrie o purpetiélli, andavano a diffonderle per
le strade della città.
Ci rimane anche il nome del
primo di questi venditori ambulanti di canzoni:
Gennaro Pennone, nativo di Casòria, il quale vendeva le
copielle a 1 grano l’una, procurando così all’Azzolino
un guadagno di 4 carlini per ogni 100 copielle.
L’ultimo ambulante di canzoni, Giuseppe Jorio,
occupò invece un angolo di Piazza Carità fino al 1960[85].
Grazie ad Azzolino, conosciamo
tuttora canzoni della prima metà dell’Ottocento, come
“Lo cardìllo ‘nnammorato” (di Pietro Labriola e Masiello
Bonito), “Don Ciccillo alla fanfarra” (di Raffaele
Colucci) e “Li capille de Carolina” (di Domenico
Bolognese).
239. E grazie a Gugliemo
Cottrau, che nel 1824 riuscì a far abbonare alle sue
raccolte di canzoni anche la Regina delle due Sicilie,
conosciamo canzoni come le tarantelle “Michelemmà” (del
1600), “Uno, doje e tre”, “Lo guarracino” e
“Cicerenella” (del 1700) e la celebre “Fenèsta vascia”
(anch’essa, presumibilmente, del 1700).
240. Un altro
tipografo-editore, Mariano Paolella (1835-1868),
fu invece il primo a pubblicare, su un foglio volante,
nel 1854, “Fenèsta ca lucìve”, le cui origini risalgono
molto probabilmente alla Sicilia del 1500.
La festa di Piedigrotta:
in epoca pagana
241. Di Piedigrotta, la storia
è nota ed antica: ingegneri, e soprattutto schiavi,
dell’epoca romana, scavarono nel tufo la famosa
crypta neapolitana ovvero una grotta che collegava
Napoli con Pozzuoli.
L’ingresso della grotta, dal
lato napoletano, era poco distante dalla tomba di
Virgilio e vi sorgeva un tempio dedicato al culto del
dio Prìapo, raffigurato con uno sproporzionato membro
maschile in quanto dio della fertilità.
Presso questo tempio, si
svolgevano orge e baccanali, opportunamente accompagnati
da musiche e strofe in versi, come è documentato nel
Satyricon di Petronio Arbitro, ed anche l’imperatore
Nerone volle parteciparvi (vedi sopra, n°229).
La festa di Piedigrotta: in epoca cristiana
242. Con il diffondersi del
cristianesimo, orge e baccanali vennero
comprensibilmente abbandonati, ma il luogo continuò in
qualche modo ad essere ritenuto sacro e destinato a
canti e danze popolari.
A partire dal 1200, là dove era
stato il tempio di Prìapo, venne costruita prima una
cappelletta e poi, a più riprese, una vera e propria
chiesa, frequentata anzitutto dai pescatori della zona e
dedicata alla Madonna detta perciò “di Piedigrotta”, la
cui festa si celebrava, e tuttora si celebra, l’8
settembre, liturgicamente festa della “Natività della
Beata Vergine Maria”.
243. Fin dai giorni precedenti,
da ogni luogo arrivavano cortei di popolo danzante, al
suono dei tipici strumenti musicali tradizionali, quali:
la antichissima tofa (una grande conchiglia
marina “soffiata” anzitutto dai pescatori); il sisco
(detto anche piffero o zufolo, antenato del flauto) che
poteva essere anche a due canne (sisco a ddoje);
la tromma o scacciapensieri; la tammorra
(tamburello) e le castagnelle (nacchere
spagnole); la rumorosissima tròccola; la
zampogna (cornamusa) di solito accompagnata dalla
ciaramella (antenata del clarinetto); il putipù
(detto anche caccavella); lo scéta-vaiàsse
(antenato del violino); e il tricca-ballàcche;
mentre più sofisticati, anche se non per questo ignorati
dal popolo, erano il calasciòne (detto anche
“tiorba a taccone”, una specie di antenato della
chitarra) e il nobile mandolino.
|
 |
I guagliuni, da sinistra a destra dell'osservatore,
suonano sceta-vaiasse, sisco, caccavella (o putipù), scacciapensieri
(o tromma) |
La festa
nazional-popolare borbonica
244. L’usanza si mantenne e si
sviluppò durante i due secoli del viceregno spagnolo, e
quando infine Carlo III di Borbone sconfisse gli
austriaci nella battaglia di Velletri (1744)
ripristinando così l’indipendenza del Regno, pensò
intelligentemente di trasformare la festa popolare in
una vera e propria festa nazionale, collegando la
“Natività di Maria” con la nascita del Regno delle due
Sicilie sotto la dinastia borbonica: introdusse, così,
all’interno della festa, una grande parata militare
guidata personalmente da lui stesso, e carri allegorici
che venivano allestiti dalle varie corporazioni di arti
e mestieri.
Ne sortì “una festa civile,
militare e religiosa unica al mondo; e
diciamo unica al mondo perocché in verità non sappiamo
dirlo di altra che riunisca tutti gli elementi sociali
in una sì bella manifestazione di ossequio alla
religione”.
Quello borbonico fu dunque il
periodo di maggior splendore della festa, con
caratteristiche compiutamente nazional-popolari, di
corrispondenza fra popolo ed istituzioni.
245. Il popolo rimaneva infatti il primo protagonista,
come è testimoniato dalle celebri parole che Luigi
Settembrini, detenuto politico nel carcere di S. Maria
Apparente in Napoli dal maggio del 1839 al luglio del
1841, scrisse poi nelle sue “Ricordanze della mia vita”
(Parte prima, cap. XIV):
“Costui (Luigi Liguoro, uno dei “custodi” del
carcere) non era un tristo uomo, e volentieri si
intratteneva meco a parlare …
E un altro giorno mi disse: - Ieri (3 ottobre 1839),
s’è aperta la strada ferrata sino a Portici. C’era il
re, c’era una compagnia di lancieri con le banderuole
spiegate fuori i vagoni. Quanta gente di qua e di là! In
quindici minuti si è volati a Portici. Che bellezza!
quindici minuti! e si anderà sino a Castellammare in
un’ora!
Signor mio, il mondo s’è mutato. Se vedeste la via
Toledo che la sera è illuminata
a gas
[87], vi parrebbe una galleria, una sala da ballo.
Ma io spero di vedervi presto passeggiare per Toledo, e
salutarvi, e allora vi ricorderete di me …
Una mattina … udii di lontano una voce di donna che
cantava soavemente, e mi parve come balsamo sovra una
piaga. Si trovò ad entrare il Liguoro, ed io lo
domandai: “Chi è che canta così bene?” “È mia figlia.”
“E che canzone canta?” “La canzone nuova: Te voglio
bene assaje e tu non pienze a me. Vi piace? Ebbene
le dirò che la canti spesso”.
246. Ed il Settembrini aggiunge: “Ogni anno a la festa
di Piedigrotta l’8 di settembre il popolo napolitano va
nella grotta di Pozzuoli, e lì l’uno sfida l’altro a
cantare improvviso, e la canzone giudicata più bella si
ripete da tutti, è la canzone dell’anno. Ce ne sono
delle belle; questa fu tra le bellissime ed io non posso
ancora dimenticarla.
Così, tre cose belle furono in quell’anno (1839):
le ferrovie, l’illuminazione a gas, e Te voglio bene
assaje”.
Te voglio bene assàje
(1839): i versi e la musica
247. La canzone che aveva
attirato l’attenzione di Settembrini e che è rimasta
fino ad oggi indimenticata, rimane la più celebre fra le
canzoni “d’autore (quasi) certo” del periodo
borbonico.
248. I versi sono comunemente
attribuiti a Raffaele Sacco (1787-1872), un
ottico che aveva il suo negozio, tutt’ora gestito dagli
eredi, a pochi metri da Piazza del Gesù lungo
Spaccanapoli.
In realtà, è molto probabile
che Sacco abbia solamente messo per iscritto ed in bella
forma un testo che era stato, a poco a poco, creato da
uno o più autori popolari anonimi, a lui precedenti o
contemporanei (vedi sopra, n°233) e, con l’occasione
della Piedigrotta del 1839, lo abbia presentato in un
salotto borghese durante una delle famose (feste)
“periodiche” allora abituali.
249. Il settimanale letterario “Omnibus”, in data 6
agosto 1840, a firma Raffaele Tommasi, scrive:
“Sfido chiunque dei miei lettori a dare un passo, o a
ficcarsi in un luogo, dove il suo orecchio non sia
ferito all’acuto suono di una canzone che, da non molto
da noi introdòttasi, tròvasi sulle bocche di tutti, ed è
venuta in sì gran fama da destar l’invidia dei più
valenti compositori ...
Da mane a sera, nella bottega di Girard (vedi sopra,
n°237), non si fanno altre richieste, non si domanda
di altro, non si desidera, non si vuole, non si
pretende, che la nuova canzone napoletana. L’armadio in
cui è riposta è in continuo movimento, mentre la
polvere, negli altri, copre già da gran tempo il nome di
parecchi celebrati maestri.
Sull’invenzione di essa, niente si può stabilire di
certo, perché, come avviene di tutte le belle cose,
molti sono quelli che dicono di esserne gli autori. La
maggior parte ne attribuisce il merito ad Antonio, il
più vispo e faceto lazzarone del mercato”.
|
 |
La più celebre fra le canzoni del periodo borbonico
(1839) |
250. Riguardo invece alla musica, “in epoca alquanto
recente, uno studioso, Ettore De Mura, ha rintracciato
documenti stando ai quali essa … sarebbe attribuibile
inequivocabilmente a Filippo Campanella, autore
di melodrammi ed inseparabile amico di Raffaele Sacco”[88].
Il Campanella, però, anche lui, come Sacco, molto
probabilmente arrangiò e mise sulla “carta di musica”
una melodia nata da uno o più autori popolari anonimi.
Fin dall’inizio, comunque, la leggenda popolare,
sostenuta anche da Salvatore Di Giacomo, volle che
autore della musica fosse il ben più celebre Gaetano
Donizetti, che effettivamente, quando si trovava a
Napoli, per arrotondare i redditi, scriveva anche
“canzonette” per Piedigrotta.
In una lettera del settembre 1837 all’amico Spadaro Del
Bosch, egli scrive infatti: “(Per la gran festa di
Piedigrotta) dovrei fare 12 canzonette, al solito,
per pigliarmi 20 ducati l’una, che in altri tempi le
facevo mentre coceva il riso. Ora la penna mi cade, ma
devo fare tutto, perché tutto è promesso”.
Donizetti, però, nel 1839 non si trovava più a Napoli:
chiamato dall’impresario Domenico Barbàja (vedi sopra,
n°232), egli ci venne la prima volta nel 1822; poi nel
biennio 1824-26; ed infine nel 1828, quando sposò la
pianista Virginia Vassalli e vi rimase solo fino al
1838, dopo la morte della moglie nell’epidemia di colera
del 1837.
La canzone d’autore
napoletana classica
251. Molto, se non tutto,
cambiò in seguito alla conquista sabàuda del 1860.
Nacque allora la canzone d’autore napoletana classica,
che può sociologicamente essere ben definita come:
una produzione economica e culturale della piccola
borghesia cittadina dopo l’unità d’Italia.
Articolata anch’essa, seppur in
modo diverso, intorno alla Festa di Piedigrotta, ebbe il
suo massimo splendore nel periodo liberale, cioè
all’incirca dal 1860 al 1922.
Nel periodo
fascista
subì una certa flessione, dovuta principalmente al fatto
che il regime non guardò tanto di buon occhio le
produzioni dialettali e favorì invece il sorgere, con il
binomio Bixio-Cherubini, della “canzone italiana”,
attraverso la quale, peraltro, cominciavano a filtrare,
pur con molte cautele, il fox-trot, il tango,
il charleston e finanche il jazz.
Ebbe poi una certa ripresa
dopo la seconda guerra mondiale, grazie soprattutto
al “Festival della canzone napoletana”, che si svolse
dal 1952 al 1973.
E dopo … è tutta un’altra
storia.
La canzone come
produzione economica: le origini
252. Le origini della canzone
napoletana d’autore sono tutt’altro che romantiche.
E’ ben noto, infatti, che la
canzone con la quale, nel 1880, inizia il periodo
classico, è Funiculì funiculà che fu scritta dal
giornalista Peppino Turco (1846–1903), e musicata
dal maestro, di Castellammare di Stabia, Luigi Denza
(1846-1922).
La storia di questa canzone è
stata molte volte raccontata ma poche volte ne è stato
posto in rilievo il significato storico ed economico,
davvero emblematico di quei rapporti sociali che si
erano stabiliti a Napoli dopo l’unità (vedi sopra,
n°102-104).
|
 |
Il big bang della canzone napoletana d'autore nel
1880 |
253. La Compagnia Cook, diretta
dal milanese ing. Olivieri e di proprietà del finanziere
Ernesto Emanuele Oblieght, aveva costruito per la prima
volta una linea “funicolare” sul Vesuvio, inaugurata il
6 giugno 1880.
La funicolare stentava però a
trovare clienti, perché napoletani e turisti, un po’ per
paura, un po’ per amore della tradizione, preferivano
continuare a servirsi dei cosiddetti “Ciceroni del Real
Vesuvio” ovvero delle apposite guide locali, che
permettevano di affrontare la scalata fino al cratere,
di notte, alla luce delle fiaccole e degli stessi
bagliori del vulcano, seduti su di un asino o su una
portantina sorretta da garzoni, in alcuni punti
legandosi addirittura con cinghie di cuoio agli
“ardimentosi” visitatori, per garantirne la sicurezza.
|
 |
Salita al Vesuvio |
|
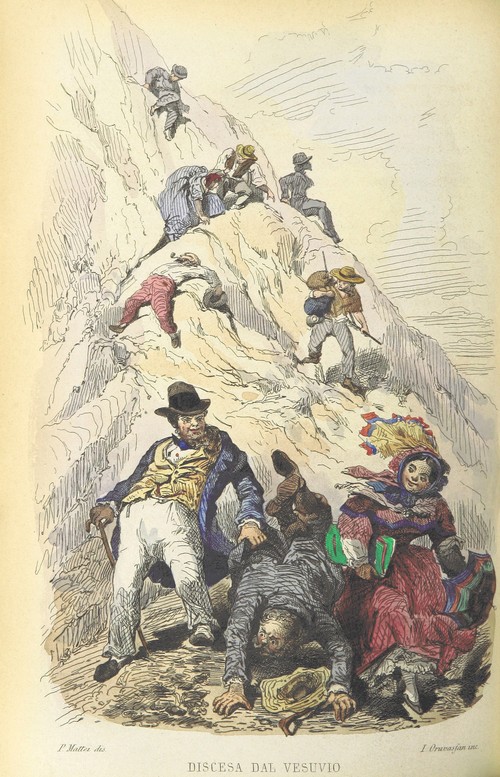 |
Discesa dal Vesuvio |
254. Si trattava di un sistema
che, per quanto primitivo, costituiva tuttavia una
risorsa economica per alcune famiglie della zona. E
questo sistema stava resistendo anche alla “intrusione”
della Compagnia Cook, se non che … il giornalista
Peppino Turco (senza essere pagato da nessuno?) scrisse
la celebre canzone per “convincere” la gente a servirsi
della funicolare.
La canzone, pubblicata peraltro
dalla Casa editrice musicale milanese “Ricordi” che
aveva aperto un sua sede a Napoli già dal 1864, spopolò
alla Piedigrotta di quel 1880, ed assurse da subito a
fama mondiale.
255. In ultima analisi
(economica), era però semplicemente la prima grande
operazione pubblicitaria dopo l’unità d’Italia, che
andava a tutto vantaggio di capitali non
napoletani (la Casa editrice Ricordi e la Compagnia
Cook) ed a tutto svantaggio, invece, della già
misera economia locale; tranne ovviamente … quello che
guadagnò Peppino Turco, che non dovette essere nemmeno
molto.
Il maestro Luigi Denza, dal
canto suo, lavorò invece certamente gratis perché
compose la musica della canzone, coinvolto da Peppino
Turco, mentre si trovava in vacanza nell’albergo che la
sua famiglia aveva a Castellammare.
|
 |
Gli azionisti della Compagnia brindano
all'inaugurazione della Funicolare del Vesuvio |
La canzone come
produzione economica: gli sviluppi
256. Il vero e proprio “big
bang” di Funiculì funiculà nel 1880 non mancò
tuttavia di avere ricadute anche sull’asfittica economia
locale: e così accadde che, mentre altrove la grande
borghesia imprenditoriale impiantava fabbriche e
produceva merci di vario tipo, la piccola borghesia
napoletana si diede, invece, a produrre … canzoni.
Per alcuni decenni, la vera, e
forse unica, industria locale napoletana fu
l’industria della canzone:
“La casa editrice Bidèri,
regina del mercato per la canzone napoletana, aveva a
disposizione un’azienda tipografica d’avanguardia, con
50 operai, capace di produrre immagini a tre colori con
la zincografia. Aveva messo a contratto decine di
musicisti, poeti e parolieri, e produceva in media 60
canzoni all’anno, oltre a quelle per la festa di
Piedigrotta che, da sola, richiedeva da 80 a 300 canzoni
all’anno.
Questa era la produzione di un
solo editore. Esperti del settore propongono di
moltiplicare questi numeri per 10, onde avere un’idea di
questa copiosa produzione”[89].
257. Ferdinando Bidèri
(1851-1928) aveva infatti ereditato, dal padre
Pietro e dal nonno Emmanuele, la omonima casa editrice
(vedi sopra, n°235) e, oltre a stampare libri di
Salvatore Di Giacomo, Ferdinando Russo e la prima
edizione de “L’innocente” di Gabriele D’Annunzio,
divenne il principale editore musicale della canzone
napoletana classica: gli anni della sua vita coincidono
con quelli del massimo splendore di questa.
|
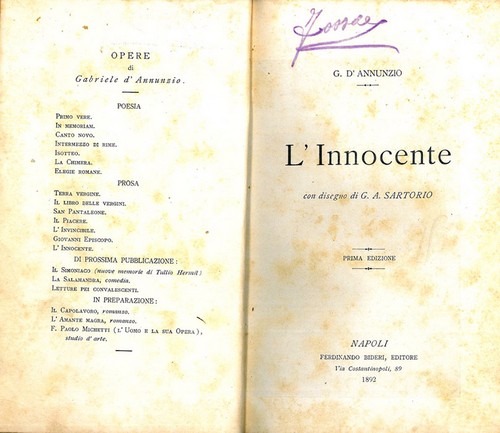 |
L'innocente di Gabriele D'Annunzio nella edizione
Bideri |
Teodoro Cottrau e “Santa
Lucia”
258. Anche Teodoro Cottrau
(1827-1879) ereditò da suo padre Guglielmo, nel
1847, la casa editrice musicale (vedi sopra, n°237) e,
servendosi pure di un periodico dal titolo “L’eco del
Vesuvio” che durò fino al 1870, ne continuò con fervida
passione l’opera di pubblicazione di antiche canzoni
popolari, aggiungendone altre di sua personale
composizione, ed altre ancora di cui “si attribuiva
spudoratamente la paternità” (Vittorio Paliotti).
259. E’ legata al nome di Teodoro Cottrau la celeberrima
“Santa Lucia” che può essere considerata come la canzone
che fa da “ponte” fra il periodo borbonico e quello
liberale.
Teodoro Cottrau la pubblicò a suo nome nel 1850. Il
testo era in napoletano, probabilmente ispirato alle
parole di un autentico “barcarolo” del borgo di S. Lucia
che invitava indigeni e forestieri a salire sulla sua
barca per fare il giro del golfo; la musica si rifaceva
invece ad un’aria della “Lucrezia Borgia” di Donizetti:
Comme se frícceca la luna chiéna!
Lo
mare ride, ll'aria è serena!
Vuje che facìte 'mmiezo a la via?
Santa Lucia, Santa Lucia!
Stu
viento frisco fa risciatàre:
chi
vo' spassàrse jenno pe mmare?
È
pronta e lesta la varca mia!
Santa Lucia, Santa Lucia!
La
tènna è posta pe fa' 'na cena;
e
quanno stace la panza chiéna
non
c'è la mínema melanconìa.
Santa Lucia, Santa Lucia!
|
 |
La canzone che fa da ponte fra il periodo borbonico e
quello liberale |
260. L’incanto della musica
suscitò attenzione fin da subito ma il testo in
napoletano, dopo il 1860, apparve evidentemente troppo
“volgare” e troppo poco “romantico” ai nuovi consumatori
piccolo-borghesi, tanto che il Cottrau dovette
commissionare ad Enrico Cossovich un testo riveduto e
corretto in italiano:
Sul
mare luccica l'astro d'argento;
plàcida è l'onda, pròspero il vento.
Venite all'agile barchetta mia!
Santa Lucia, Santa Lucia!
Con
questo zèffiro così soave
oh
com'è bello star sulla nave!
Su
passaggeri, venite via!
Santa Lucia, Santa Lucia!
In
fra le tende bandìr la cena
in
una sera così serena
chi
non dimanda, chi non desìa?
Santa Lucia, Santa Lucia!
261. Da allora, la canzone è
stata tradotta, si può dire, in quasi tutte le lingue
del mondo, ma il confronto fra il testo in napoletano,
realistico, popolaresco e robusto, e quello in italiano,
svenevolmente sentimentale ed oleografico, vale di per
sé a mostrare il passaggio fra due epoche della storia
di Napoli.
Le case editrici
musicali nel periodo liberale
262. Nel frattempo, le case
editrici musicali si moltiplicavano.
Nel 1864, come detto, giunse a
Napoli la milanese Ricordi che nel 1880 si assicurò
Funiculì funiculà.
Nel 1883 nacque la
“Santoianni”, dal nome del fondatore Peppino Santoianni.
Poco dopo, la “Società Musicale
Napoletana” di Beniamino Carelli, docente al
Conservatorio di S. Pietro a Maiella.
Nel 1899, la “Gennarelli” del
commerciante di pianoforti Enrico Gennarelli.
Nel nuovo secolo, nel 1901, “La
Canzonetta”, fondata dal poeta Francesco Feola e dal
musicista Giuseppe Capolongo.
Fra il 1911 e la Prima guerra
mondiale, irruppe sulla scena la “Poliphon”, filiale
napoletana della omonima società di Lipsia in Germania,
che il proprietario, l’industriale tedesco Massimo
Weber, affidò alla direzione del grande poeta napoletano
Ferdinando Russo.
E nel 1916 anche E.A. Mario
costituì, col suo nome, una propria casa editrice
musicale.
“All’inizio del Novecento, le
case editrici musicali a Napoli erano ben 96” (Vittorio
Paliotti).
263. Dopo la Prima guerra
mondiale, nel 1920, il poeta Rocco Galdieri fondò la sua
“Amena”.
Nel 1923 l’italo-americano
Antonio De Martino la “S. Lucia”.
E nel 1934, già in epoca
fascista, Libero Bovio, insieme ai musicisti Gaetano
Lama, Ernesto Tagliaferri e Nicola Valente, diede vita a
“La bottega dei quattro”.
L’evoluzione tecnologica:
il pianino
264. Intanto, anche i mezzi
tecnologici andavano evolvendo: alle tradizionali
“copielle” ed alle raccolte di canzoni si era già
affiancato, nell’ultimo decennio del secolo, il
“pianino” (propriamente, “organo di Barberia”, forse dal
nome dell’inventore, il modenese Giovanni Barberi).
Esistente già dal Settecento,
il pianino conobbe però il suo periodo di massimo
splendore nella Napoli di fine Ottocento ed inizio
Novecento.
|
 |
Un pianino con le copielle |
265. I pianini furono importati
dal Nord, fino a che il cavalier Vittorio Fassone, lui
stesso autore delle musiche di celebri canzoni come
‘A tazza ‘e cafè su versi di Giuseppe Capaldo e
‘Ncoppa a l’onna su versi di Libero Bovio, non fondò
in Largo Tarsia la prima fabbrica napoletana di
pianini, nel 1910.
L’ultimo
costruttore di “rulli” per pianini fu invece un certo
Pasquale Barbato, avente officina in Vico Dogliuolo al
Vasto ma avente anche (ahi, lui!) una moglie e 5 figli
da mantenere; il quale Barbato, dunque, nel 1959 cessò
la sua attività e si trasferì a Milano, perché i soli 21
pianini ambulanti ormai rimasti a Napoli non erano più
sufficienti per consentirgli di mantenere, con quel
lavoro, la sua (numerosa?) famiglia.
La canzone come produzione economica: veduta d’insieme
266. Nel 1889, un giornale
scriveva: “Ben 7.223 sono le canzoni fatte quest’anno
per la Festa di Piedigrotta; la vena canzonatoria,
come si vede, è al rialzo”.
In questo contesto, dunque,
“giravano a mille i meccanismi produttivi del sistema
industriale costruito intorno alla canzone.
Editori, commercianti, piccoli
imprenditori, facevano a gara nel finanziare le
manifestazioni musicali, l’allestimento dei carri, le
sfilate commerciali, gli album delle canzoni, le
copielle dei testi, gli spartiti, le cartoline
musicali, le canzoni réclame.
Artisti come Edoardo Dalbono e
Gian Battista De Curtis creavano splendenti scenografie.
I grandi magazzini “Mele” e
“Miccio” erano protagonisti, con i loro album di
canzoni, le loro sfilate, i palchi davanti ai negozi, i
concorsi, le réclame dappertutto.
Il sodalizio fra Mele e Bideri
era granitico, ed avrebbe realizzato la più bella e
artistica produzione di manifesti e cartelloni
pubblicitari in Italia”[90].
La canzone come
produzione culturale: Orfeo
267. Lo scrittore napoletano
Raffaele La Capria cita opportunamente
[91] la vicenda dell’avvocato Nicola Fasùlo
il quale, nel 1799, “fu capace di trarsi fuori da una
situazione disperata con mezzi che meritano di essere
chiamati artistici”.
Catturato dai làzzari per
essere condotto a morte in quanto giacobino, tanto parlò
“nella più spedita e arguta favella napoletana,
incantando chi lo ascoltava” che, con l’aiuto della
parola aggiunto a quello della cèlia, prima riuscì a far
sorridere i suoi terribili aguzzini per “far loro
perdere la feròcia” e, alla fine, li rabbonì e li fece
ridiventare “umani” a tal punto che essi lo lasciarono
libero.
Per usare una ben nota immagine
mitologica, fece come l’antico Orfeo che “ammansiva col
canto le fiere”.
|
 |
Il mitico Orfeo ammansisce col canto le fiere |
268. Laddove non si voglia
tener conto del fatto che l’avvocato Fasùlo, di lì a
poco tempo, finì comunque i suoi giorni sul patibolo, la
sua vicenda può essere presa come emblematica della
“strategia inconscia” adottata dal ceto medio borghese
verso la plebe, nella Napoli post-unitaria.
“Non dovette, infatti, agli
stessi mezzi ricorrere istintivamente la piccola
borghesia per reagire alla paura della plebe e alla
minaccia che dalla plebe le veniva? Non dovette
incantare col dialetto e far perdere la feròcia a quella
parte della popolazione che l’avrebbe altrimenti
sopraffatta?”[92].
La canzone come
produzione culturale: Graziella
269. A sua volta, lo scrittore
e poeta francese Alphonse de Lamartine (vedi sopra,
n°233), nel suo celebre romanzo del 1852, intitolato
“Graziella” ed ambientato nell’isola di Procida,
racconta di due giovani studenti francesi, che vivono
per qualche tempo ospiti della famiglia di un povero
pescatore.
Ad un certo punto, i due
studenti vengono invitati da quella famigliola,
ovviamente analfabeta, a leggere qualcosa ad alta voce
dai loro libri; e così essi leggono da tre libri: “Le
ultime lettere di Jacopo Ortis” di Ugo Foscolo; le
storie di Tacito; ed il romanzo “Paolo e Virginia”
(1787) dello scrittore francese Jacques-Henri
Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), amico e
discepolo del più celebre Jean-Jacques Rousseau.
|
 |
Ritratto di Graziella di Horace Vernet (1789-1863) |
270. Ed ecco le reazioni
dell’uditorio popolare:
“Quei poveri pescatori non
capivano perché Ortis si disperasse e si
uccidesse, quando poteva gioire di tutte le voluttà
dell’esistenza: passeggiare senza far nulla, guardare il
sole, amare la propria amante e pregare Dio sulle rive
verdi e ubertose del Brenta … Perché tormentarsi –
dicevano - per delle idee che non scendono sino in fondo
al cuore? Che cosa gli importa che a Milano regnino gli
austriaci o i francesi? E’ un pazzo se si cruccia tanto
per cose simili - E non ci ascoltavano più.
Quanto a Tacito, lo
capivano ancor meno … Tacito non è popolare e noto che
fra i politici e i filosofi … Per comprenderlo, bisogna
aver vissuto in mezzo ai tumulti della vita pubblica, o
nei misteriosi intrighi dei palazzi e delle corti. Che
cosa resta di queste scene, se ne togliamo la libertà,
l’ambizione e la gloria? Tali sono i tre
grandi attori di quei drammi. Ma queste tre passioni
sono ignote al popolo … ce ne accorgemmo perché la
lettura non suscitava che freddezza e stupore.
Una sera, tentammo di leggere
Paul et Virginie: lo tradussi io, leggendolo,
perché lo conoscevo bene e lo sapevo quasi a memoria …”
271. E’ la
storia di due bambini cresciuti sull’isola Mauritius (al
largo del Madagascar ed allora colonia francese) dalle
loro due madri, abbandonate dai rispettivi mariti. Le
due famiglie vivono unite come una sola, in mezzo alla
natura e nella devozione cristiana. Divenuti
adolescenti, i due ragazzi si innamorano, ma la madre di
Virginie decide di mandarla a studiare in Francia presso
una ricca e antipatica zia zitella.
Durante il viaggio di ritorno dopo alcuni anni di
dolorosa lontananza, la nave su cui Virginie si trova,
fa naufragio a pochi metri dalla riva d’approdo. Lei
muore sotto gli occhi del suo amato, pur di non
“disonorarsi” togliendosi i vestiti per nuotare. Paul si
dispera e muore di dolore pochi mesi dopo di lei. Li
seguono a breve distanza le rispettive madri, i due
vecchi servi africani e il loro cane.
La storia è narrata all’autore da un vecchio solitario
che dice di aver conosciuto di persona i due fanciulli e
si offre di raccontarne le tristi vicende.
272. “Appena ch’io ebbi
cominciato la lettura, le fisionomie del nostro piccolo
uditorio mutarono, prendendo una espressione attenta e
raccolta, segno di una evidente commozione … avevamo
toccato la nota che vibra all’unisono nell’anima di
tutti gli uomini di qualsiasi età e di qualsiasi
condizione sociale, la nota sensibile, universale, che
riassume in una sola armonia la verità eterna dell’arte:
la natura e l’amore”.
continua
[71] “La
letteratura a Napoli” in La scuola
cattolico-liberale e il romanticismo a Napoli, a
cura di C. Muscetta e G. Candeloro, Torino,
Einaudi, 1972.
[72] Vedi
n°99 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.
[73]
Antonio Ghirelli – Storia di Napoli”, Ed.
Einaudi, 1973.
[74]
Vedi: Francesco De Sanctis – “Schopenauer e
Leopardi”, in “Rivista contemporanea”, 1858.
[75] Vedi
nn°111-114 in “Il periodo liberale dal 1887 al
1896”.
[76] Vedi
n°87 in “Il periodo liberale dal 1887 al 1896”.
[77]
Francesco Barbagallo – “Napoli, belle èpoque”,
Ed. Laterza, 2015.
[78]
Barbagallo, op. cit.
[79]
Francesco de Bourcard – “Usi e costumi di Napoli
e dintorni, descritti e dipinti”, Vol. I (1853)
e Vol. II (1858), Stabilimento Tipografico del
Cav. G. Nobile, Vicoletto Salita a’ Ventaglieri
num. 14.
[80] de
Bourcard, op.cit.
[81] Vedi
n°10 in “Il periodo borbonico dal 1734 al 1790”.
[82]
Alphonse de Lamartine – “Graziella”, 1852.
[84]
Vittorio Paliotti – “Storia della canzone
napoletana”, Ed. Newton e Compton, 1992.
[86] de
Bourcard, op. cit.
[87] Vedi
n°135 e nota 26 in “Il periodo liberale dal 1876
al 1887”.
[89]
Barbagallo, op. cit.
[90]
Barbagallo, op. cit.
[91]
Raffaele La Capria – “L’armonia perduta”, 1986.